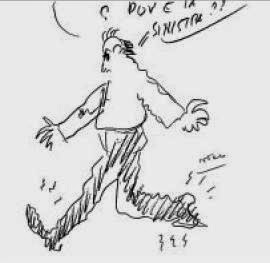Luchino
Visconti nacque il 2 novembre 1906 a Milano.
Era
destrimane.
Il
suo ultimo film fu L'Innocente*. Nella prima scena la sua mano
destra sfoglia il libro di D'Annunzio da cui è tratto il film. Solo
la mano destra, anche quando la pagina voltata resta in aria o quando
la pagina da sfogliare resiste, aderendo a quella successiva.
Federico
Fellini nacque il 20 gennaio 1920 a Rimini.
Era
destrimane.
Il
suo ultimo film fu La voce della luna. Nel 1993 ricevette il
Premio Oscar alla carriera, il quinto dopo quelli a La Strada
(1954), Le Notti di Cabiria (1957), Otto e mezzo (1963)
e Amarcord (1973), come migliori film stranieri.
Visconti
era un forte fumatore (almeno 80 sigarette al giorno, fino ad
arrivare a 120) e forte bevitore di buon caffè. Il 27 luglio del
1972, di ritorno dalla Tunisia per una breve vacanza dalle riprese di
Ludwig, mentre si trovava a Roma con alcuni amici tra cui la
sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, tentò di bere dello champagne ma
posò il bicchiere e si appoggiò alla poltrona, era pallido. Fu
colpito da un ictus nell'emisfero cerebrale destro.
Ricoverato in una
clinica romana, presentava emiparesi sinistra, eloquio fluente e
immutata ironia: “Fortunatamente, mi ha colpito
sul lato destro [del cervello], se fosse stato il sinistro sarebbe
stata dura, perché a sinistra c'è il centro del linguaggio e
dell'intelligenza, se nel mio caso ve ne sia mai uno”. Appena le
condizioni cliniche lo resero possibile, fu trasferito all'ospedale
di Zurigo (14 agosto), in Svizzera, sotto le cure di Hugo Krayenbühl
che programmò sessioni intensive di riabilitazione motoria.
Visconti
lasciò l'ospedale a fine settembre e nella sua residenza di
Cernobbio fu improvvisata una sala di montaggio per terminare i
lavori di Ludwig.
A fine novembre tornò a Roma dove si trasferì in un piccolo
appartamento che facilitasse i suoi spostamenti quotidiani.
L'emiparesi sinistra migliorò fino a permettergli di muoversi
lentamente con un bastone. Continuò a lavorare, a teatro per Tanto
tempo fa di Harold Pinter, all'opera
con Manon Lescaut
di Giacomo Puccini e poi al cinema con Gruppo
di famiglia in un interno. Il ritorno
al cinema per Visconti segnò il passaggio da grandi scene a riprese
in ambienti circoscritti, abitati da pochi personaggi.
Non
ci sono descrizioni cliniche dei disturbi neuropsicologici presentati
da Visconti assieme ai deficit motori dell'emilato sinistro del
corpo. Le iipotesi includono il neglect o eminegligenza spaziale
unilaterale (difficoltà a orientare l'attenzione verso l'emispazio
opposto alla lesione), l'agnosia visiva (difficoltà nel
riconoscimento di oggetti o nella loro integrazione, vedi anche Il pittore che non sapeva più dipingere come prima e un falso e Un bambino con agnosia visiva ha una memoria visiva delle cose?), l'anosognosia (incapacità a riconoscere
i propri disturbi sensoriali o motori, ad es. l'emiparesi).
 | ||||
Esempi
classici di copia e disegno spontaneo
in pazienti affetti da
neglect sinistro.
|
Il maggiore ricorso ai primi piani e la perdita di spazialità sono stati individuati come i due indizi cinematografici dei deficit neuropsicologici visuospaziali causati all'ictus. Si aggiunga a questi - negli ultimi film - la collocazione di molti elementi decorativi alla destra delle scene (Blanke e Pasqualini 2012).
L'ultimo film L'innocente fu
tratto dal romanzo omonimo di Gabriele D'Annunzio. Ed è quel romanzo
che la mano destra del regista sfoglia lentamente, superando le
ostilità delle pagine, all'inizio del film (Dieguez, Assal eBogousslavsky 2007).
Durante le riprese, Visconti rifiutò il bastone
ma mentre camminava in casa cadde e si fratturò la gamba destra,
quella non paralizzata. Per continuare il lavoro dovette spostarsi in
sedia a rotelle. 'Nonostante questa sedia a rotelle, eccomi qui,
pronto a dirigere un altro film. La prossima volta, forse mi farò
dare una barella, ma non potrò mai rinunciare.”
Morì il 17 marzo
del 1976 mentre era allettato per un'influenza, nella sua camera,
assistito dalla sorella.
Fellini
aveva 73 anni nell'agosto del 1993, lo stesso anno in cui gli fu
conferito l'Oscar. Il 3 agosto fu ritrovato riverso sul pavimento
della sua camera. Fu colpito da un ictus nel territorio dell'arteria
cerebrale media dell'emisfero cerebrale destro.
Rimane
nella storia anche per essere stato un caso neuropsicologico studiato
approfonditamente da Cantagallo e Della Sala (1998). Il 20 agosto
Fellini fu trasferito al Centro di Riabilitazione San Giorgio di
Ferrara: presentava un grave deficit sensoriale e motorio
dell'emilato sinistro del corpo, eloquio fluente, deficit di un
settore del campo visivo caratterizzato da una quadrantanopsia
inferiore sinistra e un florido neglect. Non manifestava anosognosia.
Conservava immutata ironia nel chiedere che il suo biglietto da
visita venisse modificato in “FF, Scoagulato, Emiparetico,
Eminattento Emianestesico”.
Il
punteggio al Mini-Mental State Examination (28/30) dimostrava assenza
di deterioramento cognitivo. Non furono riscontrate difficoltà di
riconoscimento di oggetti (agnosia visiva) né difficoltà di
riconoscimento di volti (prosopoagnosia).
Fellini mostrava
sistematiche difficoltà a rilevare uno stimolo visivo a sinistra solo quando
questo venisse presentato simultaneamente a uno stimolo visivo a
destra ma non quando ciascuno stimolo fosse presentato solo a
sinistra o solo a destra, dimostrando la presenza di estinzione
visiva unilaterale.
Manifestava,
inoltre, neglect in tutte le prove standardizzate e cliniche di tipo
visuomotorio e tale disturbo migliorò solo lievemente nelle
settimane successive.
L'aspetto
straordinario dell'esame neuropsicologico era rappresentato
dall'interpretazione artistica di ogni test, resa specialmente quando
veniva richiesto a Fellini di disegnare. E così la porzione destra
di una semplice linea di bisezione (una prova in cui al paziente viene chiesto di tracciare la metà di un segmento presentato su un foglio: nei pazienti con neglect la metà si sposta verso la destra della linea) diventava ricca di personaggi o
dettagli, contrastando con la porzione sinistra, vuota.
Inizialmente,
Fellini manifestò anche dislessia da neglect: nella lettura di
parole o frasi ne ometteva la parte iniziale, una lettera, una
sillaba o una parola. Gradualmente la lettura migliorò nel corso di
un mese.
Non
presentava un neglect personale: si orientava verso le proprie parti
del corpo a sinistra e a destra e le indicava correttamente su
richiesta. Dimostrava così una dissociazione tra esplorazione dello
spazio personale ed extrapersonale: su di sé riconosceva le parti a
destra e a sinistra, mentre trascurava le parti e gli oggetti lontani
da sé quando posti nello spazio sinistro a lui di fronte.
Il
lieve neglect era rintracciabile anche nel disegno spontaneo con
l'omissione di dettagli nella parte sinistra rispetto alla destra.
Tali deficit regredirono completamente a due mesi dall'ictus, fino a
restituire a Fellini lo stile artistico premorboso.
Quei
due mesi furono dedicati alla riabilitazione intensiva dei deficit
motori e sensoriali. Fellini non poté riprendere le sue attività.
Il 14 ottobre un secondo ictus aggravò le sue condizioni. Trasferito
al Policlinico Umberto I di Roma in gravi condizioni fu circondato da
amici e politici, paparazzi e giornalisti. Morì il 31 ottobre.
Se si conserva la consapevolezza del neglect, ci si può chiedere allora: "Dov'è la sinistra?".
*Il
sito dedicato al Maestro Luchino Visconti è www.luchinovisconti.net,
attualmente è in vendita.
Cantagallo
A, Della Sala S. (1998). Preserved insight in an artist with
extrapersonal spatial neglect. Cortex, 34, 163–189.
Dieguez
S, Assal G, Bogousslavsky J. (2007). Visconti and Fellini: From Left
Social Neorealism to Right-Hemisphere Stroke. In Bogousslavsky J,
Hennerici MG (eds): Neurological Disorders in Famous Artists –
Part 2. Front Neurol Neurosci. Basel, Karger, 2007, vol 22, pp
44–74.
Blanke
O, Pasqualini I. (2012). The riddle of style changes in the visual
arts after interference with the right brain. Frontiers in Human
Neuroscience, 5, 154:1-10.